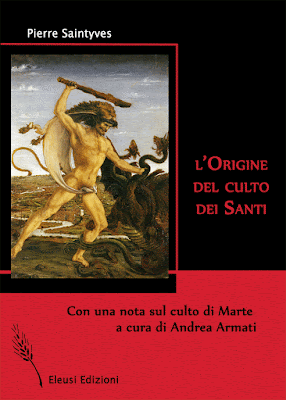Domenica 19 dicembre alle ore 17 e 30 avrò l'occasione di presentare il libricino Ambarabaciccìcoccò / Tre Civette sul comò : storia di un maleficio presso la Libreria Esoterica Cavour di Perugia.
Credo non ci sia location migliore!
La libreria infatti è a due passi dal Museo Archeologico dell'Umbria, dove si trova un ingrediente preziosissimo per cucire la nostra storia: la collezione degli Amuleti di Giuseppe Bellucci.
Il Bellucci era un medico perugino con la passione per il magico che raccolse ai primi del '900 la più grande collezione di amuleti moderni italiani.
Non fu affatto facile farlo. Molti venditori, sentendolo parlare, erano assaliti dal terrore: un diavolo poteva aver assunto le sue fattezze per ottenere gli amuleti e usarli poi contro di loro!
Nell'introduzione al suo libro sugli amuleti, Bellucci racconta questa storia che oggi sembra assurda:
" Molto spesso ebbi a lottare con quella diffidenza straordinaria, che, volendo raccogliere oggetti di tal genere comunemente s'incontra, avendo a fare con genti sospettose, credule, gelose fino allo scrupolo dei loro sentimenti e dei loro pensieri;
con genti paurose, che nella semplice dimanda relativa a determinate credenze, a particolari sentimenti, intravedono il pericolo di esser colpite dai funesti effetti del malocchio, dai malefizi o dalle fatture delle streghe e degli stregoni, dalle astuzie o dalle blandizie del diavolo.
È credenza generale difatti, che le streghe, gli stregoni e i diavoli possano presentarsi agl'incauti sotto le parvenze più belle, più simpatiche, più seducenti; possano presentarsi talora anche sotto la veste di un galantuomo e valersi perfino dell'intermediario di persone generalmente riconosciute, quali esempi di rettitudine e di specchiata onestà!* "
Le civette che si trasformano in aitanti giovani e seducono la figlia del dottore, vi ricordano qualcosa?
---Nota
*Cfr. Un capitolo di psicologia popolare : gli amuleti, Perugia : Unione Tipografica Cooperativa, 1908, pp. 5-6 (Ristampa anastatica - Il Formichiere, Foligno 2012).
martedì 8 dicembre 2015
lunedì 9 novembre 2015
Gemellaggi pagani, presentazione ad UmbriaLibri!
Domenica prossima 15 novembre ad UmbriaLibri presso l'abbazia di San Pietro si terrà alle 17:00 la presentazione ufficiale de "L'Origine del culto dei Santi" di Pierre Saintyves, nell'AULA C del suggestivo Chiostro delle Stelle (il terzo chiostro dall'ingresso!).
Coadiuvato dal professor Franco Mezzanotte, mostrerò per l'occasione una serie di 'doppioni' sacri, santi che sembrano dèi ma non lo sono...
Come questa deliziosa Santa Caterina d'Alessandria miniata da Taddeo Crivelli a metà '400, che ha con sè la ruota del martirio.
Il libraio parigino Henri Estienne nel '500 fu il primo a pensare che sotto l'iconografia bizzarra di Caterina d'Alessandria, una santa del tutto leggendaria, si nascondesse la dèa Fortuna e la sua ruota.
In effetti, se prendiamo Evrart de Conty ed il suo Libro degli eccessi amorosi dove è miniata una dèa Fortuna nell'atto di far girare la Ruota, le somiglianze balzano subito all'occhio!
I denti della ruota e l'aureola cucita sulla testa di Caterina sembrano essere gli unici elementi a distinguerla da Fortuna.
Eppure esistono delle raffigurazioni in cui perfino i denti della ruota spariscono e Caterina si ritrova in testa una più regale corona, come in questa miniatura tratta dal Salterio Burnet conservato ad Aberdeen.
Quella di Caterina che trionfa sul nemico pagano sembra più una Ruota simbolica che uno strumento di tortura!

Se il tema vi stuzzica, non mi resta che darvi appuntamento a domenica...
lunedì 28 settembre 2015
Poveri beati & Poveri sfigati:
san Francesco e i suoi 'colleghi' straccioni
Essere poveri è sempre stata una disgrazia?
Diamo un'occhiata a questa bella miniatura tratta dal Libro del Biadaiolo in cui è raffigurato un triste effetto delle carestie:
la Cacciata dei poveri da Siena.

« A Siena nel 1329, dopo la decisione dei Nove di non mantenere più con elargizioni di cibo i poveri della città, scoppiarono violenti tumulti.
[...]
Soffocata la rivolta seguirono una dura repressione con arresti, bandi, torture, impiccagioni, e infine la decisione di cacciare tutti i poveri fuori dalle mura della città [1]. »
In basso a destra, un gruppo di straccioni viene sospinto fuori da soldati armati fino ai denti:
un'operazione di Ordine pubblico in piena regola.
Eppure nel MedioEvo fare il povero dava anche accesso a dei veri privilegi.
Un nome a caso:
Francesco di Bernardone, il Re dei poveri benedetto da Dio,
aveva diritto ad un trattamento speciale, sia quando era ospite del potente cardinale Ugolino sia quando soggiornava nei palazzi vescovili.
Le fonti francescane ce lo ricordano spesso, ma l'aneddoto del piatto al pesce squalo mi ha sempre fatto sbellicare:
" Quando era gravemente infermo nel palazzo vescovile di Assisi, i frati lo pregavano di mangiare.
Francesco rispose: « Non ho voglia di mangiare; se però avessi di quel pesce che si chiama squalo, forse lo mangerei ».
Ebbe appena espresso questo desiderio quando si fece avanti un tale con un canestro dove erano, ben cucinati, tre grandi squali e pasticci di gamberi, che il padre santo mangiava volentieri.
Glieli inviava frate Gerardo, ministro a Rieti.
I frati, ammirando la divina provvidenza, lodarono il Signore che aveva provveduto al suo servo un alimento che, essendo inverno, non era possibile trovare in Assisi [2]."
Mi sovviene un dubbio:
il poverello sarà mica morto per indigestione?
Note alle immagini ---
_La miniatura sopra, con una balena che vomita pesci, proviene dal manoscritto Ashmole 1511, visibile nel sito della Bodleian Library: folio 86v.
_La miniatura in apertura mostra la Cacciata dei poveri da Siena: folii 57-58r.
Wikipedia dedica al Libro una pagina.
Note al testo ---
[1] Il passo è citato da un bel libro di Arsenio e Chiara Frugoni: Storia di un giorno in una città medievale, Editori Laterza, maggio 2004, p. 80.
[2] Specchio di perfezione, Capitolo 111 (ff 1811).
Lo stesso aneddoto è riportato nella Leggenda perugina o Compilazione di Assisi (ff 1599).
Post correlato ---
Una guerra tra 'Poveri': quando si faceva a gara per vivere di elemosine.
Diamo un'occhiata a questa bella miniatura tratta dal Libro del Biadaiolo in cui è raffigurato un triste effetto delle carestie:
la Cacciata dei poveri da Siena.

« A Siena nel 1329, dopo la decisione dei Nove di non mantenere più con elargizioni di cibo i poveri della città, scoppiarono violenti tumulti.
[...]
Soffocata la rivolta seguirono una dura repressione con arresti, bandi, torture, impiccagioni, e infine la decisione di cacciare tutti i poveri fuori dalle mura della città [1]. »
In basso a destra, un gruppo di straccioni viene sospinto fuori da soldati armati fino ai denti:
un'operazione di Ordine pubblico in piena regola.
Eppure nel MedioEvo fare il povero dava anche accesso a dei veri privilegi.
Un nome a caso:
Francesco di Bernardone, il Re dei poveri benedetto da Dio,
aveva diritto ad un trattamento speciale, sia quando era ospite del potente cardinale Ugolino sia quando soggiornava nei palazzi vescovili.
Le fonti francescane ce lo ricordano spesso, ma l'aneddoto del piatto al pesce squalo mi ha sempre fatto sbellicare:
" Quando era gravemente infermo nel palazzo vescovile di Assisi, i frati lo pregavano di mangiare.
Francesco rispose: « Non ho voglia di mangiare; se però avessi di quel pesce che si chiama squalo, forse lo mangerei ».
Ebbe appena espresso questo desiderio quando si fece avanti un tale con un canestro dove erano, ben cucinati, tre grandi squali e pasticci di gamberi, che il padre santo mangiava volentieri.
Glieli inviava frate Gerardo, ministro a Rieti.
I frati, ammirando la divina provvidenza, lodarono il Signore che aveva provveduto al suo servo un alimento che, essendo inverno, non era possibile trovare in Assisi [2]."
Mi sovviene un dubbio:
il poverello sarà mica morto per indigestione?
Note alle immagini ---
_La miniatura sopra, con una balena che vomita pesci, proviene dal manoscritto Ashmole 1511, visibile nel sito della Bodleian Library: folio 86v.
_La miniatura in apertura mostra la Cacciata dei poveri da Siena: folii 57-58r.
Wikipedia dedica al Libro una pagina.
Note al testo ---
[1] Il passo è citato da un bel libro di Arsenio e Chiara Frugoni: Storia di un giorno in una città medievale, Editori Laterza, maggio 2004, p. 80.
[2] Specchio di perfezione, Capitolo 111 (ff 1811).
Lo stesso aneddoto è riportato nella Leggenda perugina o Compilazione di Assisi (ff 1599).
Post correlato ---
Una guerra tra 'Poveri': quando si faceva a gara per vivere di elemosine.
sabato 5 settembre 2015
L'Origine del culto dei Santi: gemellaggi pagani.
Mi sono sempre divertito a cercare le analogie tra icone cristiane e dèi pagani.
Ora ho raccolto alcuni di questi 'gemellaggi' in un libro.
In occasione della traduzione de "L'Origine del culto dei Santi" di Pierre Saintyves, il gioco è iniziato dalla copertina...
Tutti gli amanti dell'arte Rinascimentale conoscono l'Ercole che abbatte l'Idra di Antonio del Pollaiolo (sopra).
Viceversa, a pochissimi è noto questo San Michele che abbatte il drago attribuito a Piero del Pollaiolo, fratello di Antonio, eseguito a metà '400 copiando spudoratamente l'Ercole!
Scherzi dell'Umanesimo?
Non proprio.
Cambiare il vestito ad un dio pagano per trasformarlo hic et nunc in qualcosa di 'evangelico' è stata sempre una prassi degli evangelizzatori.
Prendiamo la Trinità cristiana: tre persone in una.
Un cerebrale paradosso teologico che molti artisti espressero come tre uomini diversi, ma perfettamente identici!
Al santuario di Vallepietra nel Lazio è presente una di queste tante immagini di cui qui riporto una stampa.

La triade divina non era affatto sconosciuta agli antichi.
Rimasi di stucco, anni fa, al Louvre quando vidi questo fantastico altorilievo con la trinità divina che si adorava a Palmira nel primo secolo...

Al centro Baalshamin, il Signore che governa i cieli.
Alla sua destra, il dio Sole Malakbel; alla sua sinistra è, invece, il dio lunare Aglibol.
Le tre persone divine governano il cielo con attributi diversi, ma sono poste sullo stesso piano perché dotate di poteri equipollenti.
Ne L'Origine du culte des saints, Saintyves spiegava che il rincorrersi degli dèi per secoli da una sponda all'altra del Mediterraneo diede origine a delle vere e proprie 'mascherate', di cui i nostri leggendari santi cristiani erano solo l'ultima versione.
Come negare per esempio che San Pietro, il custode delle Chiavi della Chiesa, sia una parodia cristiana del dio Giano bifronte, il custode delle porte antiche, raffigurato con le chiavi in mano?
----- Nota alle immagini
[1] L'immagine di Giano riportata qui sopra è una xilografia tratta da Vincenzo Cartari, Le imagini delli dei degl'antichi, 1608.
[2] Il bassorilievo da Palmira presente al Louvre si può vedere indicizzato anche su Wikipedia.
Contro il tempio del dio Baalshamin a Palmira recentemente si sono accaniti i guerriglieri islamici, con una ferocia che ricorda vagamente quella dei cavalieri Visigoti che demolirono il tempio di Demetra ad Eleusi.
Corsi e ricorsi storici...
giovedì 6 agosto 2015
Sulle tracce della dèa Flora
al Tempietto di San Michele Arcangelo.
Ecco un libro memorabile del '500 perugino:
Commento con figure all'Architettura di Vitruvio in volgar lingua del pittore e architetto Gianbattista Caporali [1], fresco di stampa il primo aprile del 1536...
Al contrario della ricca archittettura classica, l'architettura nell'Alto Medioevo era l'arte del riuso.
Le chiese (spesso) erano costruite rammendando qua e là pezzi antichi, come un vestito di Arlecchino.
Proprio Caporali, scrivendo del Tempietto di San Michele a Perugia, ci fornisce una notizia preziosa.
« Questi capitelli colle colonne loro e di bei mischi e d'altre varie pietre di pregio dure le quali abbiamo e che erano ad un tempio dedicato alla dèa Flora lontano dalla nostra città di Perugia cinque miglia che si dice hoggi il nome del castello di Civitella d'Arno.
Questo Tempio fu guasto [...] e portate le spoglie dentro di Perugia la dove alla porta della Regione Septentrionale ne fu ornata una chiesa ortogona chiamata al presente sant'Agnolo come è notissimo [...]. » [2]
Sarà stato pure 'notissimo' ai tempi di Caporali, ma oggi quasi nessuno a Perugia conosce la storia di quelle colonne.

È così che nei secoli bui dell'Alto Medioevo si eressero molte chiese, spogliando templi che non avevano più motivo di esistere.
Per costruire una bella chiesa si smontava pezzo per pezzo un vecchio tempio pagano e il gioco era fatto!
Gli Dèi erano caduti in disgrazia.
Note al testo ---
[1] Il libro è il prodotto più originale dell'editoria perugina nel '500, zeppo d'illustrazioni su architetture visionarie.
Il contratto di edizione tra l'editore Giano Bigazzini e gli stampatori fu siglato nel 1532, ma l'Opera era così impegnativa che il libro uscì solo quattro anni dopo.
Cfr. Andrea Capaccioni, Lineamenti di storia dell'editoria umbra: il Quattrocento ed il Cinquecento, Volumnia, Perugia, 1996, p. 49.
Il libro è visionabile alla Biblioteca Augusta, con la seguente collocazione: ANT I.G 84 .
[2] La citazione è tratta dalla pagina 90 verso del libro, di cui qui ho editato la riproduzione.
Sotto è la dedica al Conte perugino Iano Bigazzini, con tanto di ritratto del nobile in posa!
mercoledì 8 luglio 2015
Il potere del Sangue nelle società primitive
da san Francesco a Jodorowsky
Chi di voi ha visto Santa Sangre?
È un film grottesco (almeno così dicono i Cineasti!) girato da Alejandro Jodorowsky nel 1989: pieno di rimandi al retroterra religioso messicano e a pratiche magiche cruente.
Concha, un'acrobata del circo, è la sacerdotessa di una setta femminile che venera una santa senza braccia, violentata e martirizzata da due banditi.
Le autorità vorrebbero demolire il tempio in cui officia con le sue sorelle per oscenità: interviene il Vescovo.
Concha lo conduce all'interno del santuario dove, al centro di un salone ricoperto da ex-voto, si trova la grande vasca che raccoglie il sangue della santa.

Il vescovo osserva sconvolto gli orridi ex-voto affissi alle pareti, e le pitture che illustrano la leggenda della 'santa'.
Poi si china ad esaminare il liquido nella vasca... e scopre trattarsi di pittura!
Adirato, esce dal tempio e ordina alle ruspe di demolire tutto senza pietà.
Concha e il suo figlioletto, disperati, si stringono alla statua della santa in un atto estremo di resistenza.

Dietro il loro dramma c'è il problema del sincretismo tra il Cristianesimo ed un culto pagano del sangue più antico.
Un culto a cui la società Razionale moderna non lascia scampo.
Più avanti nel film Fenix, il figlio di Concha, viene iniziato alle pratiche sciamaniche dal padre che tatua a sangue sulla sua pelle un'aquila. Così l'aquila diviene il suo 'animale di potere'.

Jodorowsky conosce per esperienza diretta molte pratiche sciamaniche che nel film cita con disinvoltura, ingannando lo spettatore.
A tratti, il film sembra un pulp surrealista.
In realtà, il ferimento rituale è la pratica prima dell'iniziazione sciamanica.
Come scrisse Mircea Eliade, il sangue e la carne dell'iniziato -che si è procurato le ferite- sono offerti agli Spiriti.
" [...] per entrare in contatto con gli spiriti o per ottenere gli spiriti custodi, l'aspirante si ritira in solitudine e si sottomette ad un rigoroso sistema di autotortura.
Quando gli spiriti si manifestano sotto forma animale, l'aspirante è tenuto a dar loro come cibo la propria carne. " [1]
Gli sciamani, guai a dimenticarlo, sono esponenti di un mondo preLogico.
La loro esperienza estatica lambisce il confine tra visione e finzione.
Ne La danza della realtà, Jodorowsky spiega bene come tutti gli sciamani facciano ricorso al 'sacro imbroglio'.
" Più tardi avrei scoperto che la menzogna o "imbroglio sacro" come l'ho chiamato, era una pratica usata da tutti i maestri e gli sciamani ". [2]
In queste pratiche i giochi di prestigio coesistono con le visioni allucinatorie, e compongono un mondo che a noi occidentali oggi sembra lontano anni luce.
Il nostro MedioEvo era parte integrante di quel mondo.
La leggenda dell'Impressione delle stimmate sulle carni di san Francesco da parte di una creatura alata che aveva il volto di Cristo, non è altro che la cristianizzazione di un rito sciamanico del Sangue.
Un rito che in origine era più cruento: prima che gli agiografi lo 'ingentilissero'.
Tommaso da Eccleston, nel suo Trattato sull'insediamento dei frati minori in Inghilterra (De adventu fratrum minorum in Angliam), riportò una confidenza fatta da Francesco a frate Rufino, secondo cui il Serafino una volta apparso avrebbe fatto violenza sul santo.
« San Francesco però aveva rivelato a frate Rufino, suo compagno, che, quando aveva visto l'angelo ancora da lontano, ne era rimasto molto spaventato e che l'angelo l'aveva colpito duramente [...]. » (ff 2519)
Quel 'colpito duramente' nel testo originale latino [3] è « tractavit dure » : un'espressione molto esplicita che indica proprio il fare violenza fisica.
Gli agiografi trattarono l'episodio delle Stimmate con un certo imbarazzo.
Il volgarizzatore dei Fioretti, ad esempio, scrisse che la visione di Francesco era avvenuta « non per martirio corporale, ma per incendio mentale » (ff 1920).
Tommaso da Celano, per non fare torto a nessuno, scrisse che 'quella visione si era impressa nell'animo' di Francesco, e per decenni gli uomini di Chiesa si arrovellarono per capire che volesse dire quel giro di parole.
Note ----
[1] Mircea Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi, Mediterranee, Roma, 1974, p. 130.
[2] Alejandro Jodorowsky, La danza della realtà, Feltrinelli, 2004, p. 201.
[3] Cfr. Fratris Thomae vulgo dicti de Eccleston Tractatus de adventu Fratrum Minorum in Angliam, a cura di A. G. Little, Manchester, University Press, 1951, p. 75.
Il prodigio delle stimmate:
ferimento rituale e culto dei Morti ---
Laverna, l'oscura dèa senza corpo.
I funghi e le stimmate: una visione serafica o allucinogena?
giovedì 21 maggio 2015
San Francesco e l'omosessualità:
i vizi di un buongustaio.
Le fonti francescane, a leggerle bene, restituiscono talvolta dettagli così vividi da sublimare la malizia dei commentatori posteri.
Francesco si accompagnava spesso ad un frate di grande avvenenza fisica, Masseo da Marignano (Assisi), di cui pare lodasse spesso le doti elargitegli da Madre Natura...
« E diceva che sarebbe buon frate minore colui che riunisse in sé la vita e le attitudini dei seguenti santi frati: la fede di frate Bernardo, che la ebbe in modo perfettissimo [...] la semplicità e la purità di frate Leone [...] l'aspetto attraente e il buon senso di frate Masseo » [Speculum Perfectionis, 1782].
Il "buon senso" di frate Masseo era molto apprezzato anche quando si trattava di fare elemosina.
L'autore dei Fioretti tiene ad informarci che tutta la bontà d'animo di Francesco non muoveva a carità quanto le bontà di Masseo.
« E pervenendo un dì a una villa assai affamati, andarono, secondo la Regola, mendicando del pane [...]
Ma imperò che santo Francesco era uomo troppo disprezzato e piccolo di corpo, e perciò era riputato un vile poverello da chi non lo conosceva, non accattò se non parecchi bocconi e pezzuoli di pane secco, ma frate Masseo, imperò che era un uomo grande e bello del corpo, sì gli furono dati buoni pezzi e grandi e assai e del pane intero » [Fioretti, 1841].
Fin qui, niente di peccaminoso.
Sfruttare i doni del Signore per elemosinare un tozzo di pane, è certo quanto di più lodevole ci sia!
Ma quando il volgarizzatore dei Fioretti riesce a far passare un orgasmo per ardore serafico, rasenta il genio...
« E giungendo a una chiesa, disse santo Francesco al compagno [Masseo]: "Entriamo in questa chiesa ad orare".
E vassene santo Francesco dietro all'altare, e puosesi in orazione, e in quella orazione ricevette dalla divina visitazione sì eccessivo fervore, il quale infiammò sì fattamente l'anima sua ad amore della santa povertà, che tra per lo colore della faccia e per lo nuovo isbadigliare della bocca parea che gittasse fiamme d'amore.
E venendo così infocato al compagno, sì, gli disse: "A, A, A, frate Masseo, dammi te medesimo" .
E così disse tre volte, e nella terza volta santo Francesco levò col fiato frate Masseo in aria, e gittollo dinanzi a sé per ispazio d'una grande asta; di che esso frate Masseo ebbe grandissimo stupore.
Recitò poi alli compagni che in quello levare e sospingere col fiato, il quale gli fece santo Francesco, egli sentì tanta dolcezza d'animo e consolazione dello Spirito Santo, che mai in vita sua non ne sentì tanta » [Fioretti, 1842].
Note all'immagine e al testo ---
_L'immagine sopra è una miniatura con scena omoerotica tratta da una Bible Moralisée [Codex Vindobonensis 2554] dei primi del '200, presso la Biblioteca Nazionale di Vienna (Österreichische Nationalbibliothek).
_Analizzo tutti i passi delle fonti in cui è tratteggiato il rapporto stretto tra san Francesco e frate Masseo ne
Le stimmate dello sciamano, il mito di san Francesco tra sangue e magia, Eleusi 2010, pp. 237-243.
Iscriviti a:
Post (Atom)